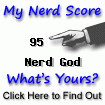Come è ormai tradizione quando si avvicina il Festival di Sanremo, prendiamo qui spunto per provare a mostrare, al di là della naturale soggettività di opinione quando si ascolta la musica, cos’è il bel canto.
Non va mai dimenticato che la musica ha uno strettissimo legame con la fisica, anzi diciamo che la musica stessa è fisica che diventa arte e che quindi ha una svariata gamma di parametri oggettivi valutabili.
Purtroppo va constatato che l’andamento generale della musica negli ultimi decenni è sempre più tendente verso una pura banalizzazione delle melodie, per non parlare dei testi, in generale sempre meno di impatto e meno densi di poesia.
Questo non vuol dire che tutto ciò che accada a un festival musicale moderno come Sanremo sia da buttare, tuttavia è davvero molto poco ciò che potrebbe rientrare in ciò che un ascoltatore con un minimo di cultura musicale seria definirebbe "musica".
Per esempio, tra le cose molto positive, lo scorso anno (2020) la straordinaria Tosca ha portato in gara un intensissimo e poetico brano intitolato
Ho amato tutto e, allo stesso tempo, abbiamo avuto il grande jazzista italiano Raphael Gualazzi in una bella rivisitazione di
E se domani in duetto con la splendida voce di Simona Molinari.
Il problema è che queste esibizioni sono ormai come gocce di acqua pura in un oceano melmoso, fatto di gente che arriva ai massimi picchi di popolarità con poco o addirittura nullo talento, abuso di strumenti di manipolazione audio come l’autotune, melodie inconsistenti, testi che non comunicano nulla.
Per fortuna nel mondo ci sono diverse eccezioni a tale tendenza, artisti (dotati di immenso talento) che ancora provano a dare una speranza alla musica moderna, ma ci sono tanti che percorrono questa strada e vengono quasi totalmente ignorati a scapito del trend commerciale malsano.
Con questa premessa, proviamo qui a fare un esperimento.
Il Festival di Sanremo vedrà 26 canzoni in gara; bene, propongo qui una sorta di “gara ideale” che fornisca un’idea generale di cosa sia il canto nella sua massima espressione e in vari generi musicali, tra passato e presente, che aiuti a sviluppare una visione più consapevole e critica di ciò che si ascolta quotidianamente.
Ecco dunque una
playlist con una selezione di 26 brani:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfvrJ-L5fmU3mq6i62VS9M0U8WS8a1eNJMa veniamo ad una breve presentazione dei brani.
1)
You’re Not From Here - Lara Fabian. Il brano è tratto dall’album
Lara Fabian, datato 2000, un album che contiene alcuni dei brani più significativi della carriera della straordinaria cantautrice italo-belga, tra cui il famoso
Adagio (di cui parleremo tra poco).
You’re Not From Here è un’incredibile ballad, che trova il suo apice nella frase “And I fly”, in cui la voce immensa della Fabian fa letteralmente volare l’ascoltatore con la musica.
2)
Too Much Love Will Kill You - Queen. I Queen e il band leader Freddie Mercury (1946-1991) non hanno bisogno di presentazioni.
La storia intorno alla suddetta canzone è interessante. Il brano è stato infatti originariamente pubblicato dal chitarrista, compositore (e astrofisico) dei Queen Brian May nel 1992, tuttavia il pezzo era già stato scritto sin dal 1988. Pochi anni dopo la morte di Mercury i Queen decisero di lavorare su un album postumo, in cui inserirono pure
Too Much Love Will Kill You facendo uso della traccia vocale di Mercury, registrata tra il 1988 e il 1989. Tale versione venne pubblicata come singolo il 26 febbraio 1996 e costituisce uno dei brani più intensi della prodigiosa discografia della band.
3)
The Lady is A Tramp - Ella Fitzgerald. La Fitzgerald (1917-1996) è stata una delle più grandi dive dell’epoca d’oro del jazz. Regina dello “scat vocal”, ossia di particolari e complicatissimi virtuosismi tipici della musica jazz, vinse ben 14 Grammy Awards. La ascoltiamo qui in una frizzante ed entusiasmante versione del brano, del 1937,
The Lady is A Tramp, facente parte del musical
Babes in Arms dei noti Richard Rodgers e Lorenz Hart e diventato un vero e proprio standard del jazz.
4)
I’m a Fool to Want You - Billie Holiday. Un’altra tra le mitiche dive dell’epoca d’oro del jazz è proprio Billie Holiday (1915-1959), spesso soprannominata Lady Day. Anche se non dotata dell’estensione vocale della Fitzgerald, la Holiday seppe assicurarsi il suo posto nella storia della musica grazie ad un timbro caratteristico e ad una capacità interpretativa unica. Un esempio lampante di tale capacità lo troviamo proprio nel brano
I’m a Fool to Want You, un brano del 1951 scritto nientemeno che da Frank Sinatra (testo) insieme a Jack Wolf e Joel Herron.
La versione della Holiday che ascolterete è quella tratta dall’album
Lady in Satin (1958), penultimo album registrato dalla cantante. L’interpretazione fornita dalla Holiday rende il brano una perla speciale da ascoltare e riascoltare.
5)
Only One Road - Céline Dion. Passiamo ora a quella che è forse la voce più straordinaria dell’epoca moderna della musica (per epoca moderna intendo il periodo che va dal 1990 ad oggi, periodo in cui man mano la musica popolare ha iniziato il suo percorso involutivo).
Le capacità di belting sostenuto e di emettere note perfettamente risonanti della Dion sono di primissimo livello. Oltre a questo, l’aspetto forse più straordinario della sua voce (specialmente nel suo periodo migliore, anche se è sempre riuscita a preservare ottimamente il proprio straordinario strumento) è il fatto di poter passare in un attimo dall’essere dolce come il miele a graffiante e incisiva come una lama tagliente. Ciò l’ha resa adatta ad approcciarsi con successo ad una moltitudine di generi musicali diversi assolutamente incredibile, dal pop al rock, dal jazz alla dance, oltre che ad accompagnare altri straordinari artisti in duetti memorabili. Ascoltiamo qui il brano
Only One Road, tratto dall’album
The Colour of My Love (1993), una tra le canzoni che più mette in evidenza le abilità appena menzionate della Dion.
6)
Fa Che Non Sia Mai - Eramo & Passavanti. Anche la musica italiana è ricca di perle memorabili. Qui abbiamo una bellissima canzone (scritta da A. De Angelis e Bungaro) di un duo di talenti che parteciparono con questa alla selezioni per Sanremo Giovani del 1997: la cantante Barbara Eramo e il pianista Claudio Passavanti. La voce della Eramo è qualcosa di sublime e di un livello difficilmente riscontrabile nelle produzioni musicali italiane odierne. Il brano venne registrato ed inserito nell’album
Oro e Ruggine (1998) del duo.
7)
Across Endless Dimension - Dimash Qudaibergen. Passiamo ora ad un brano del 2020 composto dal regista e compositore italiano, Piergiuseppe Zaia, per la colonna sonora del film
Creators - The Past. La voce è quella di colui che è senza dubbio la migliore voce maschile in circolazione al mondo, un “alieno” dotato di oltre 6 ottave di estensione vocale e in grado di spaziare agevolmente tra i vari registri della voce umana: il giovane kazako Dimash Qudaibergen. Anche Dimash, come la Dion, è in grado di dosare come vuole la sua voce e passare da suoni soavi e paradisiaci sino a note pungenti e stratosferiche, come il “Touch the sky” intonato alla fine della suddetta canzone.
8)
I’ve Got You Under My Skin - Frank Sinatra & Bono. Passiamo dalla migliore voce maschile della musica odierna a colui che non per caso venne soprannominato “The Voice”: il mitico Frank Sinatra (1915-1998). Sinatra è forse la figura che più di tutte è riuscito a fare da connubio tra la musica jazz pura (egli iniziò la sua carriera come cantante nella nota orchestra del trombonista Tommy Dorsey) e la canzone popolare. Negli ultimi anni della sua vita, precisamente nel periodo 1993-1994, Sinatra pubblicò un paio di album di memorabili duetti,
Duets e
Duets II, tra cui troviamo proprio quello con leader della band rock irlandese U2, Bono. Il brano è un altro dei cosiddetti jazz standard, scritto nel 1936 nientemeno che da Cole Porter per il musical
Born to Dance. Ottenne una candidatura come miglior canzone agli Oscar nel 1937, ma non vinse il premio perché questo fu assegnato ad un altro capolavoro, ossia
The Way You Look Tonight, che fu peraltro un altro cavallo di battaglia di Sinatra.
9)
Impossible (Orchestral Version) - Nothing But Thieves. I Nothing But Thieves sono un gruppo alternative rock britannico formatosi nel 2012. La voce principale, Conor Mason, è davvero tra le migliori del panorama odierno del genere. Quello che andiamo ad ascoltare è uno dei brani più noti della band,
Impossible, ma in una versione orchestrale che mette ancora più in luce le abilità canore ed interpretative di Mason.
10)
I’m Not A Warrior - Sonnet Son. Canzone intensissima interpretata da una voce a dir poco magistrale, quella della sudcoreana Son Seung-yeon, più nota come Sonnet Son, vincitrice della prima edizione (2013) di
The Voice of Korea. Sia ben presente che questo non è un brano di K-pop, o meglio, non lo è secondo l’accezione popolare che viene data a quel termine.
I’m Not A Warrior è un pezzo serio di musica, scritto da Aleena Gibson, Molly Sanden e Walter Afanasieff (già autore di memorabili canzoni per artisti del calibro di Mariah Carey, Celine Dion, Patti LaBelle, Michael Bolton e così via) che merita un’attenzione particolare.
11)
Adagio - Shirley Bassey. Come ho anticipato prima, nella playlist è presente anche l’incredibile canzone
Adagio, basata sul classico
Adagio di Giazotto (spesso attribuito erroneamente ad Albinoni). La versione originale, come già detto, si deve a Lara Fabian (e chi non l’avesse mai ascoltata corri ad ascoltarla). Qui però volevo fare una segnalazione più particolare e davvero suggestiva. L’immensa Shirley Bassey (nota ai più per le sue interpretazioni di brani colonna sonora dei film della serie 007 come
Goldfinger, ma anche per la partecipazione al festival di Sanremo 1968 con la canzone
La vita) ha registrato nel 2020 il suo ultimo album,
I Owe It All To You, all’età di 83 anni. La voce della Bassey è una di quelle perle rare che, nonostante il passare del tempo, è rimasta potente e incisiva ed è in grado di regalare ancora grandissime emozioni. Se l’
Adagio nella versione della Fabian è l’emblema della perfezione tecnica del canto, la Bassey riesce a compensare magistralmente con un’interpretazione differente accompagnata da un ottimo arrangiamento, che rendono entrambe le versioni di tali straordinarie artiste degne di lode.
12)
El Perdòn - Diana Navarro. A proposito di brani intensi,
El Perdòn, contenuto nell’album
Resiliencia (2016) della talentuosa cantante spagnola Diana Navarro, ci fa sperimentare un’esperienza sensoriale fantasmagorica. Il controllo del volume che la Navarro riesce ad ottenere in tale pezzo è a dir poco sensazionale.
13)
It Had to Be You - Barbra Streisand & Michael Bublé. L’aspetto straordinario della musica è quello di poter trasmettere un’infinità di sensazioni emotive che spaziano dal dolore puro, intenso alla gioia e allegria più sincere. L’interpretazione fornita dalla Streisand e Bublé del brano
It Had To Be You, scritto nel 1924 da Isham Jones con testo di Gus Kahn, appartiene a quest’ultima categoria. Barbra Streisand è una leggenda vivente. Attrice superba, cantante dal controllo vocale tra i migliori di sempre, tanto che si ha l’impressione che non faccia il minimo sforzo per emettere le complesse note che va ad emettere. Bublé è una delle migliori voci maschili della musica odierna, che ha preso in eredità la strada aperta dai grandi crooner del passato come il già citato Frank Sinatra, Bing Crosby, Dean Martin, Perry Como e così via.
14)
The Story - Brandi Carlile. Brano del 2007 tratto dall'omonimo album dell'ottima cantante folk rock statunitense Brandi Carlile. Anche qui è riscontrabile una prodigiosa abilità nella modulazione della voce, che parte soave all’inizio del brano e muta improvvisamente in un’emissione graffiante e pungente, adatta allo sviluppo narrativo del brano.
The Story è sicuramente tra i brani di musica pop rock più significativi del XXI secolo.
15)
Rise Up - Morissette Amon.
Rise Up è un meraviglioso brano originariamente interpretato dalla brava cantante statunitense Andra Day nel 2015. Qui però siamo di fronte ad uno di quei casi in cui un’artista di livello persino superiore riesce quasi ad oscurare una versione originale già di alta caratura! Ci stiamo riferendo alla giovane filippina Morissette Amon. L’interpretazione della Amon, dotata di una capacità tecnica assolutamente fuori dal comune, è qualcosa di sublime, tanto che spesso nei commenti alle sue esibizioni si parla di “eargasm”, termine usato nel linguaggio popolare per indicare una sensazione euforica provocata dalla musica.
16)
Lately - Stevie Wonder.
Lately è una ballata soul scritta ed interpretata dalla leggenda vivente Stevie Wonder e pubblicata nel 1980 nell’album
Hotter than July. Il critico Jason Elias scrisse a riguardo di tale brano, per via della sua proverbiale intensità emotiva: "it's enough to make a listener fall prey to an old-fashioned cry”. Direi che non c’è da aggiungere altro!
17)
If I Could - Regina Belle. Trattasi di un brano scritto da Ken Hirsch, Marti Sharron e Ronald Miller e pubblicato nell’album
Passion (1993) della cantautrice statunitense Regina Belle. Questo brano mette perfettamente in luce le abilità canore ed interpretative di altissimo livello della Belle, celebre anche per il suo duetto con Peabo Bryson in
A Whole New World, brano portante del film Disney
Aladin del 1992.
If I Could venne coverizzata successivamente anche da grandi nomi come Barbra Streisand, Céline Dion e Michael Bolton.
18)
Everything Must Change - Sarah Vaughan. La Vaughan (1924-1990), assieme alla Fitzgerald e alla Holiday, costituisce quella che si potrebbe definire la sacra trinità delle dive della musica jazz. Spesso soprannominata Sassy, ma pure Sailor e “La divina”, era dotata di una voce da contralto assolutamente stupefacente e di un controllo vocale che faceva gara a quello della Streisand. Qui ascoltiamo la sua interpretazione (Live at Rosy’s) della canzone
Everything Must Change, scritta da Benard Ighner nel 1974. Vi aspettano quasi 7 minuti di pura delizia per le orecchie.