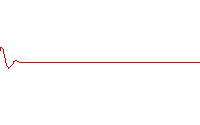Riprendiamo il nostro viaggio nei rudimenti della meccanica quantistica che avevamo cominciato tempo fa.
Ecco l'elenco delle puntate precedenti:
L'obiettivo del presente post è arrivare a derivare l'importante equazione di continuità.
Per far questo, cominciamo dicendo che, poiché $|\psi(\vec{r},t)|^2 \mathrm{d} \vec{r}$ rappresenta una probabilità, allora se noi andiamo ad integrare questa quantità su tutto lo spazio occorre che questa probabilità sia 1:
Non ha mai senso parlare infatti di una probabilità che superi 1, cioè il 100%.
Quella appena scritta prende il nome di
condizione di normalizzazione.
La condizione ci fa anche capire che le funzioni d’onda devono essere necessariamente
funzioni a quadrato sommabile.
Al tempo iniziale possiamo normalizzare all’unità la funzione d’onda, come appena detto.
Rimane un fattore di fase arbitrario che possiamo fissare a piacere perché, se mantenuto coerentemente, non avrà conseguenze fisiche.
Tuttavia, affinché tutto ciò sia coerente,
è necessario che l’equazione di Schrödinger garantisca la normalizzazione nel futuro.
Se dovessimo infatti rinormalizzare la funzione d’onda ad ogni istante, l’equazione non sarebbe più soddisfatta!
Occorre pertanto che:
Andiamo a vedere se l’equazione di Schrödinger garantisce tale conservazione della norma. Partiamo dall’equazione di Schrödinger generale
e dalla sua forma
complessa coniugata (quella dell'asterisco è un'altra notazione comune per indicarla)
Moltiplichiamo la prima per $\psi^*$ e la seconda per $\psi$, dopodiché sottraiamo. Ne risulta:
giacché
Adesso andiamo ad integrare quanto ottenuto su un volume $V$:
La norma risulta dunque conservata se vale
Se interpretiamo le funzioni $\psi$ come rappresentazioni di uno spazio vettoriale, questa relazione si può riscrivere come:
cioè
la conservazione della norma viene assicurata se l’hamiltoniana è un operatore hermitiano.
Scritta così potreste non aver capito molto, quindi cerchiamo di chiarire meglio cosa sia un operatore hermitiano, che è un concetto importantissimo ai fini della meccanica quantistica.